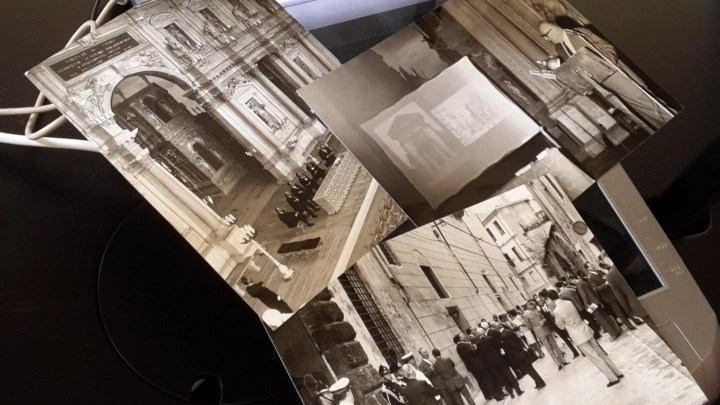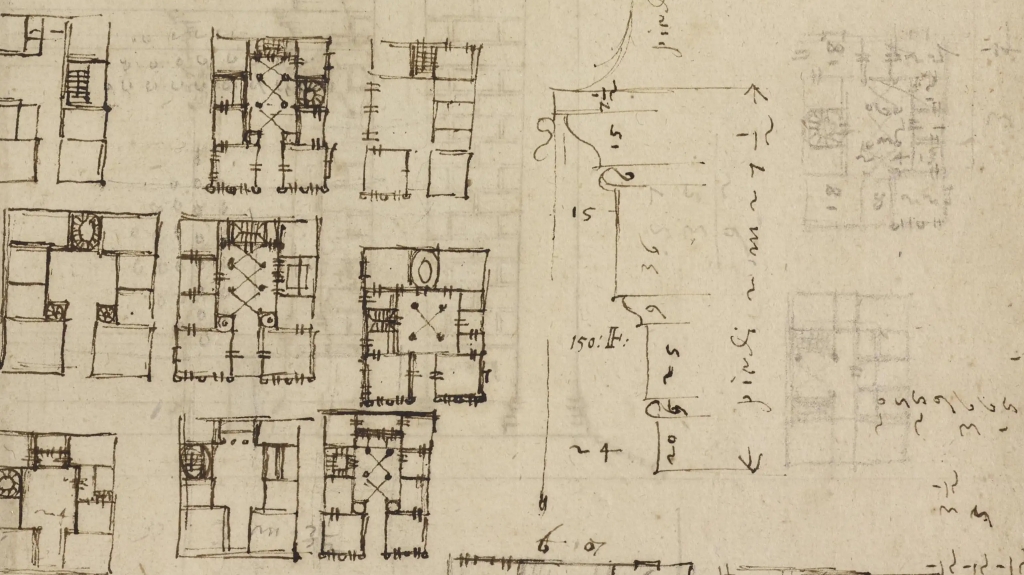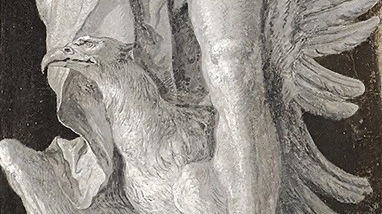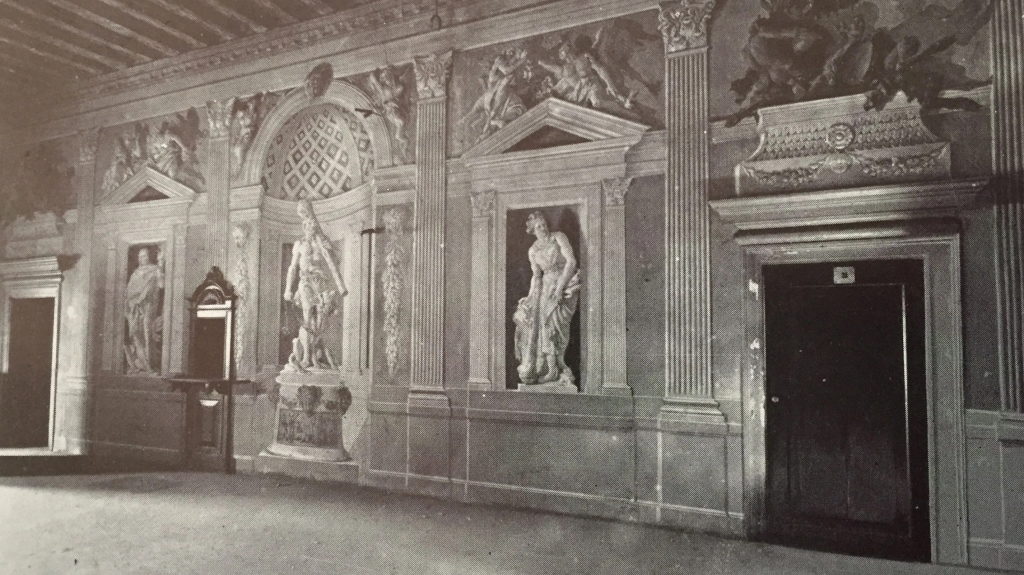Il blog dei tirocinanti universitari e degli studenti in PCTO che trascorrono da poche settimane a parecchi mesi al Palladio Museum: «Abbiamo deciso di raccontare che cosa succede dietro le quinte quando il Palladio Museum allestisce una nuova sala, organizza una mostra, realizza un’iniziativa… un modo informale per rendere tutti partecipi del lavoro di ricerca e di valorizzazione del Centro Studi e Museo palladiano».
-
Iscriviti
Sottoscritto
Hai già un account WordPress.com? Accedi ora.